Smartwork o ufficio? Le neuroscienze lo sanno!
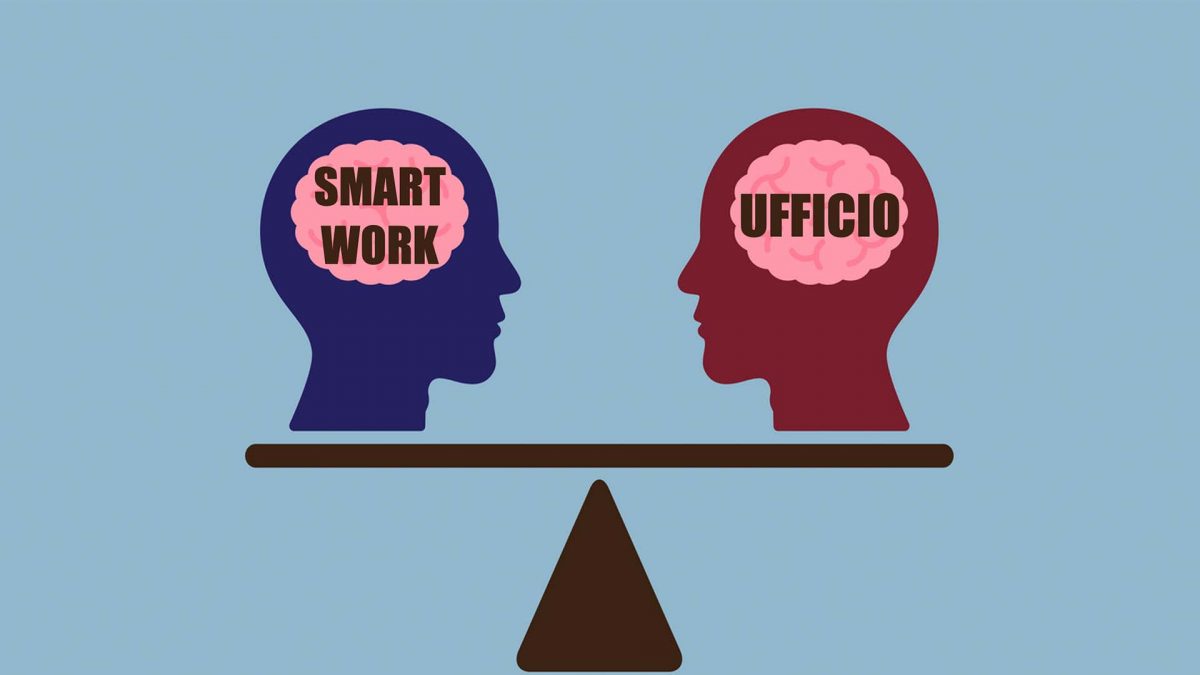
In questi infiniti mesi di pandemia, il fenomeno smartwork è stato studiato da molti punti di vista, dall’efficienza aziendale all’adeguamento dei contratti. Raramente si è approcciato il tema partendo dalle differenze tra le persone nel “lavorare da remoto”, valorizzando l’immensa ricerca neuroscientifica a disposizione.
Due premesse sono necessarie. Il tema smartwork non va affrontato con pregiudizio da tifoseria. Alcune persone sono più adatte e produttive quando lavorano da remoto, altre funzionano meglio in ufficio, a parità di impiego. Il miglior funzionamento non riguarda unicamente i risultati, ma anche il benessere psicofisico, condizione essenziale per mantenere l’efficacia lavorativa nel lungo periodo. Il secondo aspetto riguarda le scelte delle imprese ad epidemia conclusa. Molte aziende adotteranno un modello ibrido. Al lavoratore sarà richiesto di scegliere se e quanto smartworking fare nella settimana lavorativa. Questa libertà impone la responsabilità, ad ogni persona, di riflettere su di sé. Dove funziono meglio? Sono più produttivo in smartwork o in ufficio? Dove mi sento a mio agio?
Gli studi di neuropsicologia sono utili per capire le caratteristiche che predicono produttività e benessere in smartwork. Individuando, al contrario, le persone a cui consigliare di rientrare in ufficio il più possibile e prima possibile. 2 caratteristiche sono fondamentali: la tendenza alla procrastinazione e la socievolezza.
La procrastinazione. Il professor Pychyl, della Carleton University, ha confermato studi iniziati nel lontano 2012, agli albori del “telelavoro”. La prima ricerca, firmata da Clark, Karau e Michalisin, è stata pubblicata sul “Journal of Management policy and practice”. Il titolo: telecommuting and personality. L’obbiettivo era studiare il rapporto tra efficacia nel “tele-lavoro”, così si chiamava nel 2012, e configurazioni di personalità. L’ipotesi dimostrata è che l’ufficio agisca come un ascensore. Quando siamo dentro, tutti seguiamo un protocollo non detto. L’ufficio definisce orari di arrivo e partenza, prevede codici di comportamento che dettano il tempo fuori e dentro l’attività. Le persone che tendono a procrastinare lo fanno meno all’interno di un ufficio, rispetto a quando lavorano da casa. Chi fa fatica ad organizzarsi, tende a distrarsi o rimanda i lavori più frustranti, è meno efficace da remoto. Al contrario chi non procrastina, non ha necessità di scrivanie e orari. Ogni lavoro, anche il più bello del mondo, prevede compiti noiosi e stressanti. Se tendi a procrastinare, lo smartwork non fa per te. Se fai quasi sempre quello che devi, tollerando bene la frustrazione, l’ufficio non serve.
La socievolezza. In una recente dissertazione, il professor Davis della Leeds University ha ripreso un’ampia metanalisi del 2018, pubblicata sull’European Journal of psychology, dal titolo: “Stress in remote work”. Lo scopo della ricerca era capire quali soggetti soffrivano maggiormente il lavoro da remoto. Tutti i dati convergono sul fatto che le persone estroverse tendono ad avere difficoltà quando lavorano da casa. Coloro che fanno affidamento sull’ambiente sociale per godersi la professione e ricercano motivazione nel confronto, si trovano svantaggiati da remoto. Le videocall non hanno il calore delle chiacchere davanti alla macchinetta del caffè. Una telefonata non è come un pranzo tra clienti o colleghi. Le persone socievoli traggono energia nell’essere immersi in un mondo di relazioni. Se sei una persona socievole, dopo un certo periodo in smartwork, ti troverai con alti livelli di stress ed insoddisfazione, al di là degli incarichi lavorativi. Se il calore della relazione ti manca, ti conviene rientrare in ufficio. Se invece sei una di quelle persone che sta bene anche sola e non coltiva rapporti di amicizia sul lavoro, allora lo smartwork è la soluzione ideale.
Un’altra questione interessante riguarda il rapporto tra lavoro da remoto e salute mentale. Un recente studio del 2020, uscito su LSE Business review, realizzato dal dott. Ogbannaya e dal suo team, ha risposto in maniera esaustiva. Il titolo dell’articolo di ricerca: “Remote working is good for mental health?”. Il target del lavoro era confermare o falsificare le asserzioni sentite sui media riguardo l’impatto positivo o negativo del lavoro da remoto. Le conclusioni sono solide in quanto si basano sulla raccolta dei principali sintomi di malessere psicologico, realizzate su campioni enormi di persone in tutta Europa. Nel 2020, moltissime professioni sono andate in smartwork, il covid ha generato l’opportunità di avere una base dati amplissima. Mai nella storia così tante persone avevano lavorato da remoto e per un tempo così lungo. A cosa giunge questa ricerca? In pratica lo smartwork non genera alcun problema di salute mentale, né tanto meno riduce i sintomi se considerato come variabile a sé stante. L’idea quindi che migliori o peggiori lo stato di salute mentale, ottimizzando l’equilibrio famiglia-lavoro oppure peggiorando la qualità della vita per la continua necessità di essere connessi non è confermata dai dati empirici. Tuttavia, nel caso di persone che mostravano una bassa stabilità emotiva, ovvero che già prima del Covid, avevano una storia di malessere emotivo, lavorare da remoto acuisce la situazione. L’aumento nel consumo di psicofarmaci legati alla regolazione dell’umore e le richieste di supporto psicologico per la gestione dell’ansia sono state maggiori da parte di chi soffriva di disturbi mentali, con una diagnosi acclarata, prima del covid. Gli studi mostrano come lo smartwork possa essere per alcuni soggetti psicologicamente meno stabili, o comunque più fragili, un fattore precipitante che peggiora la salute mentale. Sulla popolazione generale non si notano associazioni statisticamente significative in senso positivo o negativo.
L’approccio neuropsicologico allo smartworking dimostra l’inutilità di ogni ideologia preconfezionata. Ogni scelta dipende dalla personalità del soggetto, da come sta e cosa fa la persona quando lavora da casa. Dalla sua storia pregressa, dalla sua rete di relazioni, da come vive il lavoro, dal senso che assume nella sua vita. Il resto sono idee che ignorano la più grande certezza sugli esseri umani: nessun cervello è uguale all’altro.
